|
Dall'albero di Adamo, racconta la "Legenda Aurea", è stato ricavato il legno della croce, senza croce e senza Cristo, vero uomo e vero Dio, non ci può essere redenzione.
 Per queste ragioni la Crocifissione per Romanino non è solo una meditazione sul dolore nella tradizione medievale dello Stabat Mater, nè un atto d'accusa contro la malvagità dell'uomo, carnefice del suo Dio. Maria, la madre dolorosa, e il gruppo delle donne sono spostate al margine sinistro della rappresentazione, si confondono nella calca e sembrano quasi cadere fuori scena; più rilievo assumono invece i soldati che si giocano ai dadi la tunica indivisibile di Cristo e richiamano il tema, in un'età di lacerante predicazione luterana, della Chiesa che non deve essere divisa. Ai piedi della croce troviamo, avvinghiata al legno, la figura di Maddalena, che già a Betania, cospargendo di preziosa essenza di nardo i piedi di Gesù, ne aveva proclamato la divinità, ma figura centrale è Longino. Su un imponente cavallo bianco, il centurione stretto in un'armatura argentea, reclina il capo all'indietro e mostra, di profilo, un volto allungato e scavato.
Per queste ragioni la Crocifissione per Romanino non è solo una meditazione sul dolore nella tradizione medievale dello Stabat Mater, nè un atto d'accusa contro la malvagità dell'uomo, carnefice del suo Dio. Maria, la madre dolorosa, e il gruppo delle donne sono spostate al margine sinistro della rappresentazione, si confondono nella calca e sembrano quasi cadere fuori scena; più rilievo assumono invece i soldati che si giocano ai dadi la tunica indivisibile di Cristo e richiamano il tema, in un'età di lacerante predicazione luterana, della Chiesa che non deve essere divisa. Ai piedi della croce troviamo, avvinghiata al legno, la figura di Maddalena, che già a Betania, cospargendo di preziosa essenza di nardo i piedi di Gesù, ne aveva proclamato la divinità, ma figura centrale è Longino. Su un imponente cavallo bianco, il centurione stretto in un'armatura argentea, reclina il capo all'indietro e mostra, di profilo, un volto allungato e scavato.
Nello sguardo, nelle pieghe della fronte, nelle labbra appena socchiuse di quest'uomo ormai vecchio Romanino ha bloccato il tremendo interrogativo di tutti gli uomini davanti al Cristo crocifisso, ma nella mano sgranata sul petto sta il senso della risposta che scende dall'alto.
 Se la Crocifissione è il momento più alto di questo ciclo di affreschi, dove Romanino sembra riprendere, a distanza di anni, il conto aperto con il Pordenone a Cremona e, dopo l' esperienza trentina, con le tante suggestioni ponentine e i richiami classicheggianti, fa esplodere una pittura piena di foga ed eccitazione, tutte le scene contengono, pur nella loro guasta leggibilità, pagine altissime. E sono indimenticabili i ritratti, gettati all'improvviso ma con grande attenzione tipologica, di cavalieri e popolani che entrano da protagonisti nella storia sacra, e i bambini che si accapigliano ai piedi della scala dell' "Ecce Uomo", il volto di Cristo che sale al Calvario aggrappato alla Croce e il vecchio Adamo che ha poggiato un piede sulla porta scardinata del Limbo e si lascia tirar su da Cristo, ( "discesa al Limbo" immagine a fondo pagina ) consumando nello sguardo in un attimo la sua millenaria attesa.
Se la Crocifissione è il momento più alto di questo ciclo di affreschi, dove Romanino sembra riprendere, a distanza di anni, il conto aperto con il Pordenone a Cremona e, dopo l' esperienza trentina, con le tante suggestioni ponentine e i richiami classicheggianti, fa esplodere una pittura piena di foga ed eccitazione, tutte le scene contengono, pur nella loro guasta leggibilità, pagine altissime. E sono indimenticabili i ritratti, gettati all'improvviso ma con grande attenzione tipologica, di cavalieri e popolani che entrano da protagonisti nella storia sacra, e i bambini che si accapigliano ai piedi della scala dell' "Ecce Uomo", il volto di Cristo che sale al Calvario aggrappato alla Croce e il vecchio Adamo che ha poggiato un piede sulla porta scardinata del Limbo e si lascia tirar su da Cristo, ( "discesa al Limbo" immagine a fondo pagina ) consumando nello sguardo in un attimo la sua millenaria attesa.
Della decorazione dell'abside non è rimasto più nulla, ma si sa da alcune antiche descrizioni che le scene rappresentavano alcuni episodi della vita di Maria, alla quale era dedicato il santuario e che, soprattutto nella predicazione francescana, era presentata come l'intermediaria per eccellenza tra l'uomo e Dio sulla strada della salvezza. Si sono conservati invece alcuni frammenti della decorazione estema, strappati in momenti diversi e custoditi presso il Municipio di Pisogne, in attesa dell'allestimento di uno spazio espositivo adeguato.
Dalla cappella dell'Ospedale, adiacente alla chiesa, sono stati strappati nel 1964 un Cristo benedicente, due santi di cui uno identificabile in San Sebastiano ed una serie di frammenti di putti.
Due grandi scene raffiguranti l' "Adorazione dei magi" sono state invece strappate nel secolo scorso dalla parete esterna della
volta a settentrione, dopo la demolizione, nella prima metà dell'Ottocento, del portico che la proteggeva. l' "Adorazione dei Magi" era divisa in tre riquadri, ma si sviluppava come un unicum narrativo in cui comparivano, in sequenza a partire da sinistra, la "Madonna con il Bambino", l' "Arrivo dei Magi" che presentano i doni e il "Corteo" dei personaggi del seguito
con cavalli, bauli, vettovaglie... Cancellata dalle intemperie la "Madonna con il
bambino", nel 1878 si intervenne sulle altre due scene, che recentemente sono state restaurate da Romeo Seccamani.
 La più rovinata è l' "Arrivo dei Magi", dove le figure degli antichi scrutatori delle stelle si intuiscono appena, ma, come da un impasto materico indifferenziato, emerge sulla destra un gruppo di volti che Romanino ha delineato con la sua caratteristica pennellata rapida e densa, individuando negli animi di questi nobili accompagnatori, posti di fronte al mistero della divinità, sentimenti di incredulità e stupore. Molto più leggibile l'atra scena, con il "Corteo", dominata al centro dalla figura di un grande cavallo che improvvisamente s'impenna e, quasi scartando un improvviso ostacolo, s'attorciglia sui suoi muscoli possenti costringendo il cavaliere ad un difficile esercizio di equilibrio nell'aria. Attorno all'uomo, la cui veste si gonfia al vento, una folla di personaggi avanza in gruppo, esibendo cappelli di tutte le fogge e discutendo animatamente; sulla destra due servi muscolosi stanno seduti sui bauli intenti solo a qualche loro questione privata.
La più rovinata è l' "Arrivo dei Magi", dove le figure degli antichi scrutatori delle stelle si intuiscono appena, ma, come da un impasto materico indifferenziato, emerge sulla destra un gruppo di volti che Romanino ha delineato con la sua caratteristica pennellata rapida e densa, individuando negli animi di questi nobili accompagnatori, posti di fronte al mistero della divinità, sentimenti di incredulità e stupore. Molto più leggibile l'atra scena, con il "Corteo", dominata al centro dalla figura di un grande cavallo che improvvisamente s'impenna e, quasi scartando un improvviso ostacolo, s'attorciglia sui suoi muscoli possenti costringendo il cavaliere ad un difficile esercizio di equilibrio nell'aria. Attorno all'uomo, la cui veste si gonfia al vento, una folla di personaggi avanza in gruppo, esibendo cappelli di tutte le fogge e discutendo animatamente; sulla destra due servi muscolosi stanno seduti sui bauli intenti solo a qualche loro questione privata.
Non va dimenticato, ancora una volta, che una delle prime forme di teatro religioso che si conosca, insieme alla recita della Passione, è proprio la rappresentazione del corteo dei Magi. Romanino, senza dubbio, amava e sentiva proprie queste forme di teatralità, perchè vi percepiva vita e movimento, azione nel suo divenire, e le collegava alla sua umanità robusta e volitiva, di cui anche queste "guastatissime" scene sono un mirabile esempio.
Francesco De Leonardis
prima pagina
Notizie di Pisogne
|
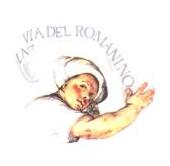



 Per queste ragioni la Crocifissione per Romanino non è solo una meditazione sul dolore nella tradizione medievale dello Stabat Mater, nè un atto d'accusa contro la malvagità dell'uomo, carnefice del suo Dio. Maria, la madre dolorosa, e il gruppo delle donne sono spostate al margine sinistro della rappresentazione, si confondono nella calca e sembrano quasi cadere fuori scena; più rilievo assumono invece i soldati che si giocano ai dadi la tunica indivisibile di Cristo e richiamano il tema, in un'età di lacerante predicazione luterana, della Chiesa che non deve essere divisa. Ai piedi della croce troviamo, avvinghiata al legno, la figura di Maddalena, che già a Betania, cospargendo di preziosa essenza di nardo i piedi di Gesù, ne aveva proclamato la divinità, ma figura centrale è Longino. Su un imponente cavallo bianco, il centurione stretto in un'armatura argentea, reclina il capo all'indietro e mostra, di profilo, un volto allungato e scavato.
Per queste ragioni la Crocifissione per Romanino non è solo una meditazione sul dolore nella tradizione medievale dello Stabat Mater, nè un atto d'accusa contro la malvagità dell'uomo, carnefice del suo Dio. Maria, la madre dolorosa, e il gruppo delle donne sono spostate al margine sinistro della rappresentazione, si confondono nella calca e sembrano quasi cadere fuori scena; più rilievo assumono invece i soldati che si giocano ai dadi la tunica indivisibile di Cristo e richiamano il tema, in un'età di lacerante predicazione luterana, della Chiesa che non deve essere divisa. Ai piedi della croce troviamo, avvinghiata al legno, la figura di Maddalena, che già a Betania, cospargendo di preziosa essenza di nardo i piedi di Gesù, ne aveva proclamato la divinità, ma figura centrale è Longino. Su un imponente cavallo bianco, il centurione stretto in un'armatura argentea, reclina il capo all'indietro e mostra, di profilo, un volto allungato e scavato.  Se la Crocifissione è il momento più alto di questo ciclo di affreschi, dove Romanino sembra riprendere, a distanza di anni, il conto aperto con il Pordenone a Cremona e, dopo l' esperienza trentina, con le tante suggestioni ponentine e i richiami classicheggianti, fa esplodere una pittura piena di foga ed eccitazione, tutte le scene contengono, pur nella loro guasta leggibilità, pagine altissime. E sono indimenticabili i ritratti, gettati all'improvviso ma con grande attenzione tipologica, di cavalieri e popolani che entrano da protagonisti nella storia sacra, e i bambini che si accapigliano ai piedi della scala dell' "Ecce Uomo", il volto di Cristo che sale al Calvario aggrappato alla Croce e il vecchio Adamo che ha poggiato un piede sulla porta scardinata del Limbo e si lascia tirar su da Cristo, ( "discesa al Limbo" immagine a fondo pagina ) consumando nello sguardo in un attimo la sua millenaria attesa.
Se la Crocifissione è il momento più alto di questo ciclo di affreschi, dove Romanino sembra riprendere, a distanza di anni, il conto aperto con il Pordenone a Cremona e, dopo l' esperienza trentina, con le tante suggestioni ponentine e i richiami classicheggianti, fa esplodere una pittura piena di foga ed eccitazione, tutte le scene contengono, pur nella loro guasta leggibilità, pagine altissime. E sono indimenticabili i ritratti, gettati all'improvviso ma con grande attenzione tipologica, di cavalieri e popolani che entrano da protagonisti nella storia sacra, e i bambini che si accapigliano ai piedi della scala dell' "Ecce Uomo", il volto di Cristo che sale al Calvario aggrappato alla Croce e il vecchio Adamo che ha poggiato un piede sulla porta scardinata del Limbo e si lascia tirar su da Cristo, ( "discesa al Limbo" immagine a fondo pagina ) consumando nello sguardo in un attimo la sua millenaria attesa. La più rovinata è l' "Arrivo dei Magi", dove le figure degli antichi scrutatori delle stelle si intuiscono appena, ma, come da un impasto materico indifferenziato, emerge sulla destra un gruppo di volti che Romanino ha delineato con la sua caratteristica pennellata rapida e densa, individuando negli animi di questi nobili accompagnatori, posti di fronte al mistero della divinità, sentimenti di incredulità e stupore. Molto più leggibile l'atra scena, con il "Corteo", dominata al centro dalla figura di un grande cavallo che improvvisamente s'impenna e, quasi scartando un improvviso ostacolo, s'attorciglia sui suoi muscoli possenti costringendo il cavaliere ad un difficile esercizio di equilibrio nell'aria. Attorno all'uomo, la cui veste si gonfia al vento, una folla di personaggi avanza in gruppo, esibendo cappelli di tutte le fogge e discutendo animatamente; sulla destra due servi muscolosi stanno seduti sui bauli intenti solo a qualche loro questione privata.
La più rovinata è l' "Arrivo dei Magi", dove le figure degli antichi scrutatori delle stelle si intuiscono appena, ma, come da un impasto materico indifferenziato, emerge sulla destra un gruppo di volti che Romanino ha delineato con la sua caratteristica pennellata rapida e densa, individuando negli animi di questi nobili accompagnatori, posti di fronte al mistero della divinità, sentimenti di incredulità e stupore. Molto più leggibile l'atra scena, con il "Corteo", dominata al centro dalla figura di un grande cavallo che improvvisamente s'impenna e, quasi scartando un improvviso ostacolo, s'attorciglia sui suoi muscoli possenti costringendo il cavaliere ad un difficile esercizio di equilibrio nell'aria. Attorno all'uomo, la cui veste si gonfia al vento, una folla di personaggi avanza in gruppo, esibendo cappelli di tutte le fogge e discutendo animatamente; sulla destra due servi muscolosi stanno seduti sui bauli intenti solo a qualche loro questione privata.