|
È
un viale diritto a condurci alla chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne, costruita solitaria sotto uno spuntone di scura roccia, ora stretta dalla strada che sale verso la montagna. Il convento fu aggiunto più tardi, nel 1580, dopo la visita di San Carlo che lo volle affidare agli agostiniani. L'edificio di Santa Maria, che ha sofferto parecchio negli ultimi
due secoli malgrado i numerosi interventi di sistemazione e restauro, si presenta come un'aula unica absidata, ancor goticheggiante, divisa in tre campate da archi acuti; la facciata esterna, molto semplice, ha un coronamento ad archetti ed un bel portalino rinascimentale, decorato a candelabre, in rossa arenaria di Gorzone, con una statua della Madonna con il Bambino nella lunetta e il monogramma bernardiniano al centro dell'architrave.
Quando " homeni da Pisogni" gli affidarono l'incarico di decorare il santuario di Santa Maria della Neve agli inizi del
quarto decennio del Cinquecento, Romanino arrivava da Trento, dove fino all'estate del 1532 era stato impegnato negli affreschi del Palazzo Magno del principe vescovo Bernardo Clesio.
 Nella polizza d'estimo del 1534 il pittore, che in tutta la sua vita fu assai poco abile ad incassare il frutto del suo lavoro, dichiara un credito di 150 lire planete nei confronti dei suoi committenti pisognesi e a quella data dunque l'opera era terminata.
Nella polizza d'estimo del 1534 il pittore, che in tutta la sua vita fu assai poco abile ad incassare il frutto del suo lavoro, dichiara un credito di 150 lire planete nei confronti dei suoi committenti pisognesi e a quella data dunque l'opera era terminata.
Inizia da qui - l'episodio di Tavernola era ormai un fatto lontano - la fase camuna del Romanino, che lo avrebbe portato, di lì a poco, anche a Breno ed a Bienno, in un percorso che è stato visto talvolta come un rifugiarsi nella periferia, tra gli umili e i semplici dove egli poteva meglio realizzare la sua ansia di libertà espressiva e la necessità di attingere alla verità delle cose attraverso la tensione e la forza di un linguaggio che sapeva unire insieme lingua e dialetto. C'era certamente anche questo nella scelta del Romanino; c'erano una qualche incomprensione provata a Trento e il predominio che la bottega del Moretto esercitava a Brescia, monopolizzando la committenza, a spingerlo fin quassù, ma sarebbe sbagliato guardare alla Val Camonica del Cinquecento come ad una terra arretrata economicamente e culturalmente, applicando gli occhi di un presente di crisi, ad un mondo che era invece vitalissimo.
Pisogne, non va dimenticato, era un importante centro di commerci, vi si scambiavano le ferrarezze che venivano dai forni fusori e dalle fucine dell'alta valle con le granaglie trasportate, via lago, dalla pianura, e con le merci viaggiavano le idee,
le forme artistiche, le esperienze religiose... C'era, se mai, in questo momento nodale del secolo, l'affermarsi, di fronte al pericolo della penetrazione luterana al di qua delle Alpi, l'esigenza di rievangelizzare, di riprendere con nuova lena la predicazione delle verità cristiane, di ripensare le espressioni della religiosità popolare per ricondurle entro gli schemi rigidi e omologanti della Controriforma.
Il progetto iconografico che Romanino è chiamato a realizzare in Santa Maria della Neve, tanto unitario e totalizzante da andar sopra alle pitture che già erano state realizzate sulle pareti del santuario, ci riporta a queste esigenze, a questo clima in cui si andava affermando una nuova spiritualità, teologicamente "corretta" e capace di aprirsi un varco anche tra gli strati più bassi della popolazione.
Il vasto ciclo degli affreschi di Santa Maria occupa la volta, l'arco santo, le pareti laterali e la facciata; originariamente si estendeva anche alla zona absidale ed, all'esterno, alla parete a settentrione ed alla cappella appoggiata al fianco meridionale.
La volta è caratterizzata da una struttura a cielo aperto con finti costoloni che segnano i campi delle vele e gli arconi trasversi, ed è decorata da 24 figure di profeti, sibille e veggenti, appoggiati in equilibrio instabile ai cornicioni; ai loro piedi stanno putti monocromi su un fondo di finto mosaico e nei
sottarchi si aprono degli ovali con altre figure di profeti.
Sull' arco santo incontriamo, in alto, il Padre Eterno e l'Annunciazione con l'Arcangelo Gabriele a sinistra e la Vergine a destra; più in basso, a far da pala a due altari successivamente eliminati, la "Discesa dello Spirito Santo" e la "Deposizione al Sepolcro". Le pareti laterali sono affrescate con grandi scene che occupano le ampie arcate acute, sotto le quali, entro
l'alta zoccolatura di finto marmo, sono inserite scene più piccole, di formato rettangolare, che rappresentano i momenti salienti della Passione, Morte e resurrezione di Cristo. Punto focale di tutta la raffigurazione è la grande "Crocifissione", che occupa l'intera controfacciata.
Un percorso di lettura che voglia trovare immediatamente un ordine consequenziale negli episodi raffigurati incontra, come è stato spesso osservato, delle difficoltà. Se il punto di partenza di questa Passione va individuato nella scena della "Cattura di Cristo nell'Orto degli Ulivi", posta all'angolo a sinistra dell'arco santo, si procede poi in senso antiorario attraverso l' "Ecce Uomo", la "Salita al Calvario", la "Crocifissione", la
"Resurrezione", la "Discesa al Limbo" e l' " Ascensione", ma una prima difficoltà è data dalla posizione della "Discesa al Limbo", che dovrebbe precedere e non seguire la "Resurrezione". Ancora più complesso il percorso delle scene minori che rappresentano, procedendo sempre in senso antiorario dall'angolo a sinistra dell'arco santo, la "Cena in casa del Fariseo", "Cristo davanti a Pilato", "Cristo flagellato", "Cristo coronato di spine", l'"Ultima Cena", la "Lavanda dei piedi" e l'"Ingresso in Gerusalemme". Questo apparente disordine è stato interpretato talvolta come un segno della bizzarria del Romanino, che non vincolato da committenti colti, avrebbe agito con ampia libertà anche nella scelta dei soggetti, dopo che gli era stato fissato il tema generale. Recentemente però Bruno Passamani ha dato una nuova convincente lettura di questo percorso iconografico che sarebbe da ricondurre alle pratiche devozionali di stampo teatrale di una confraternita di Disciplini o alla spiritualità dei Frati Minori dell' Osservanza, che in questo periodo avevano una significativa presenza in Valle Camonica.
Anche se Santa Maria della Neve era un santuario dipendente dagli "homini da Pisogni", cioè dalla vicinia, e non c'è traccia documentaria della presenza di una Disciplina in questa chiesa (mentre se ne ha per altri luoghi di culto del paese lacustre), è assai probabile che Romanino abbia voluto mettere in scena qui, con quel suo modo naturalmente drammatico di organizzare le composizioni, una specie di sacra rappresentazione per immagini sul tema della Passione. Le tradizioni camune, del resto, vanno tutte nella direzione di queste forme di spettacolo. È di Breno infatti uno dei più antichi testi drammatici del territorio bresciano, la bellissima Passio duecentesca della Disciplina di San Valentino di Breno, ancora rappresentata alla fine del XV secolo, e il famoso Padre Gregorio di Valle Camonica (1698) parla, con abbondanza di notizie, dei riti della settimana santa con processioni, Viae Crucis e "perdoni de pena" che vedevano la partecipazione di uomini e cavalli e che a Cerveno si sono conservate fino ai nostri giorni. La presenza, sulla facciata esterna di Santa Maria della Neve, di una "danza macabra", oggi scomparsa ma documentata in un rilievo grafico del secolo scorso, è un'ulteriore testimonianza del legame che c'è tra il santuario con gli affreschi del Romanino e queste forme di devozione popolare, che i Francescani avevano cercato di rinnovare, tra l'altro con la pubblicazione nel 1498 della "Devota meditazione della Passione di Nostro Signore" del padre Bernardino de Bustis.
 Gli spostamenti e le anticipazioni operate dal Rornanino servono a dividere le tre campate dell'aula di Santa Maria della Neve in tre blocchi tematici distinti in un percorso meditativo che parte dall'arco santo, cioè dove possiamo immaginare il predicatore intento ad illustrare l'itinerario della salvezza, e arriva alla parete di fondo occupata dalla grande Crocifissione. Questo percorso va letto anche in relazione al significato figurale delle Sibille e dei Profeti della volta, che sono distribuiti otto per campata, con un maschio che sta di fronte ad una femmina, e che hanno tra le
mani svolazzanti filatteri, alcuni decorati con segni incomprensibili che alludono forse all'oscurità del linguaggio profetico, altri con parole di senso compiuto, collegate al tema della Croce, sul quale Cristo ha compiuto il suo martirio.
Gli spostamenti e le anticipazioni operate dal Rornanino servono a dividere le tre campate dell'aula di Santa Maria della Neve in tre blocchi tematici distinti in un percorso meditativo che parte dall'arco santo, cioè dove possiamo immaginare il predicatore intento ad illustrare l'itinerario della salvezza, e arriva alla parete di fondo occupata dalla grande Crocifissione. Questo percorso va letto anche in relazione al significato figurale delle Sibille e dei Profeti della volta, che sono distribuiti otto per campata, con un maschio che sta di fronte ad una femmina, e che hanno tra le
mani svolazzanti filatteri, alcuni decorati con segni incomprensibili che alludono forse all'oscurità del linguaggio profetico, altri con parole di senso compiuto, collegate al tema della Croce, sul quale Cristo ha compiuto il suo martirio.
La prima tappa è quella dell'annuncio e dell'attesa; la seconda campata allude alla caduta dell'umanità nel disordine religioso e quindi, in rapporto ai tempi, nell'eresia; nella terza infine troviamo l'esaltazione della Croce come cardine dell'intera storia umana e come elemento di redenzione dal peccato attraverso la Passione di Cristo. Punto focale della riflessione diventa così la crocifissione, che Romanino rappresenta, da par suo, in una scena concitata, piena di violenza, di movimento e rumore, di cavalli scalpitanti, di bestemmie urlate, di turpe gentaglia che s'accalca intomo al Salvatore, di immenso dolore; una scena in cui s'avverte anche l'intenzione di porre l'attenzione sulla questione teologica della natura di Cristo, perchè -la lunga vicenda delle eresie dei primi secoli ce l'ha insegnato- la realtà del Cristo è la realtà della salvezza e la fede cristiana è la fede nella salvezza.
segue
Notizie di Pisogne
|
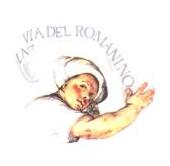



 Nella polizza d'estimo del 1534 il pittore, che in tutta la sua vita fu assai poco abile ad incassare il frutto del suo lavoro, dichiara un credito di 150 lire planete nei confronti dei suoi committenti pisognesi e a quella data dunque l'opera era terminata.
Nella polizza d'estimo del 1534 il pittore, che in tutta la sua vita fu assai poco abile ad incassare il frutto del suo lavoro, dichiara un credito di 150 lire planete nei confronti dei suoi committenti pisognesi e a quella data dunque l'opera era terminata. Gli spostamenti e le anticipazioni operate dal Rornanino servono a dividere le tre campate dell'aula di Santa Maria della Neve in tre blocchi tematici distinti in un percorso meditativo che parte dall'arco santo, cioè dove possiamo immaginare il predicatore intento ad illustrare l'itinerario della salvezza, e arriva alla parete di fondo occupata dalla grande Crocifissione. Questo percorso va letto anche in relazione al significato figurale delle Sibille e dei Profeti della volta, che sono distribuiti otto per campata, con un maschio che sta di fronte ad una femmina, e che hanno tra le
mani svolazzanti filatteri, alcuni decorati con segni incomprensibili che alludono forse all'oscurità del linguaggio profetico, altri con parole di senso compiuto, collegate al tema della Croce, sul quale Cristo ha compiuto il suo martirio.
Gli spostamenti e le anticipazioni operate dal Rornanino servono a dividere le tre campate dell'aula di Santa Maria della Neve in tre blocchi tematici distinti in un percorso meditativo che parte dall'arco santo, cioè dove possiamo immaginare il predicatore intento ad illustrare l'itinerario della salvezza, e arriva alla parete di fondo occupata dalla grande Crocifissione. Questo percorso va letto anche in relazione al significato figurale delle Sibille e dei Profeti della volta, che sono distribuiti otto per campata, con un maschio che sta di fronte ad una femmina, e che hanno tra le
mani svolazzanti filatteri, alcuni decorati con segni incomprensibili che alludono forse all'oscurità del linguaggio profetico, altri con parole di senso compiuto, collegate al tema della Croce, sul quale Cristo ha compiuto il suo martirio.