|
In piazza, in mezzo alle case, ma senza il respiro di una facciata. Per quei suoi muri curvi, per il modo in cui si inserisce nel tessuto urbano, adattandosi al percorso delle vie e al terreno in pendio, Sant'Antonio a Breno ci appare come cresciuta su se stessa, subordinando l'architettura agli spazi con un intervento minimale e quasi casuale. L'origine di Sant'Antonio è nel testamento di Giovanni fu Girardo Marone Ronchi, rogato ad Iseo il 13 novembre 1334 dal notaio Corrado de Sabio, con il quale il nobile brenese lasciò alcuni suoi beni per la costruzione di una "ecclesiam vel aliquod alium oratorium" invitando i frati di Sant'Antonio di Vienne o, in subordine, gli "huomines de Breno" a compiere l'opera;
 la chiesa attuale sorse tra il 1467 e il 1516 sulla prima cappella con una serie di interventi successivi che portarono alla costruzione di un edificio ad aula unica, diviso in tre campate trapezoidali, molto irregolari, che si allargano in direzione del presbiterio; le campate sono ricoperte da volte a crociera che si collegano alle pareti laterali con archi acuti, mentre la parete di fondo (particolare nella immagine a lato) è a tutto sesto.
la chiesa attuale sorse tra il 1467 e il 1516 sulla prima cappella con una serie di interventi successivi che portarono alla costruzione di un edificio ad aula unica, diviso in tre campate trapezoidali, molto irregolari, che si allargano in direzione del presbiterio; le campate sono ricoperte da volte a crociera che si collegano alle pareti laterali con archi acuti, mentre la parete di fondo (particolare nella immagine a lato) è a tutto sesto.
Non conosciamo esattamente l'anno in cui Romanino arrivò a Breno, ma tutti gli studiosi sono sempre stati concordi nell'affermare che gli affreschi di Sant'Antonio vengono dopo quelli di Santa Maria della Neve e li datano intorno al 1535. Lo accompagnava un garzone, Daniele Mori, che già era stato con lui a Pisogne e lo seguirà anche a Bienno; più tardi il maestro lo autorizzerà a riscuotere delle somme di denaro dai sindaci dei tre comuni valligiani, che non erano stati puntuali pagatori delle opere eseguite. È difficile però identificare la mano del giovane allievo sulle pareti affrescate o, per lo meno, su quello che oggi resta della decorazione e il valore della presenza del Mori ci sfugge del tutto. Per la chiesa di Sant'Antonio la decadenza in cominciò già alla fine del XVII secolo; sconsacrata nel 1880, fu utilizzata come caserma e anche come cinematografo; quando, all'inizio del nostro secolo, venne riaperta al culto e dichiarata monumento nazionale i guasti erano ormai irreparabili.
Romanino, a cui venne affidato l'incarico di affrescare le tre pareti del presbiterio, probabilmente dopo che nel giugno del 1534 vennero qui trasferite dalla chiesa di San Maurizio le funzioni parrocchiali, si trovò ad operare in un contesto decorativo che era già stato avviato, qualche decennio prima, da un artista
nel quale si riconosce - ma non tutti sono d'accordo - Giovan Pietro da Cemmo. Quest'ultimo aveva affrontato il tema della volta importando in valle lo schema ideato dal Foppa nella Cappella Averoldi del Carmine a Brescia e aveva collocato le figure
dei Dottori della Chiesa ed i simboli degli Evangelisti sulle imposte degli archi entro arcate aperte, caratterizzate da un ricco ornato architettonico, e le figure dei quattro Evangelisti nelle vele stellate. Inoltre, al centro della parete di fondo, Callisto Piazza aveva posto, intorno al 1527 la sua grande pala con "La Vergine in trono con il Bambino fra i santi Rocco, Sebastiano, Antonio Abate e Siro" uno dei momenti espressivi più alti del pittore lodigiano che ha lasciato tra Erbanno, Esine, Borno e Breno diverse testimonianze della sua arte.
Ricevuto l'incarico, Romanino si trovò ad affrontare la difficile e irregolare struttura spaziale della chiesa e adottò una loggia a portico che costituisce, pur nella diversa tipologia architettonica degli edifici dipinti (al colonnato ionico della parete di fondo fanno riscontro i pilastri della parete sinistra), un elemento visivo unificante, grazie al quale riuscì a riempire di figure anche la parte alta della parete, secondo un'idea, molto teatrale, che consiste nell'inserire nel contesto della scena gli spettatori che osservano dall'alto l'azione drammatica. È questo un modo di affrontare il tema spaziale che aveva le sue lontane radici
nell'armoniosa architettura che fa da sfondo all'affresco di San Pietro a Tavernola e che viene adottata altre volte: a Villongo San Filastrio (Bg), a Bienno e nelle ante di San Giorgio in Braida a Verona. Ma è anche un modo per portare chi guarda dentro il dipinto, suggerendo un processo di identificazione con gli spettatori privilegiati che si sporgono dalle balaustre nelle loro fogge diverse e agitano braccia e teste nell'animazione della conversazione, e Romanino ci chiede di condividerne i sentimenti, i moti dell'animo, le passioni di fronte a quello che avviene sul gran palcoscenico della vita.
 Difficile e complessa, a causa delle vaste lacune che interessano le zone affrescate, l'identificazione dell'iconografia, per la quale si sono suggerite letture a volte contrastanti. Non ci sono dubbi sulla parete destra che è anche la meglio conservata e raffigura alcuni episodi tratti dal libro di Daniele: Sadràch, Mesàch e Abdènego, compagni di Daniele, vengono condannati da Nabucodonosor e gettati nella fornace.
Difficile e complessa, a causa delle vaste lacune che interessano le zone affrescate, l'identificazione dell'iconografia, per la quale si sono suggerite letture a volte contrastanti. Non ci sono dubbi sulla parete destra che è anche la meglio conservata e raffigura alcuni episodi tratti dal libro di Daniele: Sadràch, Mesàch e Abdènego, compagni di Daniele, vengono condannati da Nabucodonosor e gettati nella fornace.
Il racconto biblico dice del re babilonese Nabucodonosor che fa erigere una grande statua d'oro ed ordina che, al suono delle trombe, tutto il popolo di Babilonia si prostri in adorazione davanti ad essa. I tre giovani compagni di Daniele, onorati in precedenza dal re per le loro qualità intellettuali, rifiutano di rinnegare il proprio dio e vengono gettati in una fornace ardente, ma le fiamme uccidono i soldati e lasciano indenni i condannati. Nella scena, tra gli spettatori in alto a destra, si distingue la figura di un vecchio con la veste rossa, appoggiato ad un bastone a forma di tau, che era il simbolo dell'ordine dei frati di Vienne, e non è difficile identificare nel personaggio lo stesso Sant'Antonio Abate, che in questo modo verrebbe messo in relazione con la vicenda di Daniele. Antonio Abate era infatti considerato un efficace protettore contro gli incendi, le malattie degli animali ed in particolare gli si attribuiva la capacità di guarire l'herpes dell' uomo, un male popolarmente indicato appunto come il fuoco di Sant' Antonio. La sua devozione era particolarmente diffusa in Val Camonica dove numerosi erano i forni fusori e le fucine che mettevano i lavoratori al rischio del fuoco ed a Breno, nel giorno della sua festa, si teneva mercato; i tre
fanciulli nella fornace, circondati dalle fiamme ma non consumati, potevano dunque essere immagine di fede e di speranza per i malati che chiedevano l'intercessione del santo per guarire dal tormentoso fuoco. Il tema dell'adorazione dell'idolo e del
rifiuto dell'apostasia potrebbe però riportarci anche alla repressione che nei primi decenni del Cinquecento si attuò in Val Camonica nei confronti di donne e uomini accusati di stregoneria, un peccato che l'Inquisizione considerava una forma di eresia; Marin Sanudo, che nei suoi Diari dà una descrizione del rogo a Pisogne, il 17 luglio 1518, di otto povere donne accusate di essere streghe e di frequentare il sabba sul Tonale, ricorda che in quei giorni in valle furono arse in quattro luoghi diversi "circa 64 persone maschi et femine, et altrettanti e più ne sono in persone et ne sono circa 5000", aggiungendo però che si tratta di una cifra "inextimabile". L'episodio biblico di Daniele poteva dunque valere come richiamo all'ortodossia, affermazione della verità che emerge dalla menzogna e promessa di punizione per i persecutori.
 Quasi impossibile invece arrivare ad una definizione certa dei soggetti delle altre due pareti, perche ci si trova di fronte ad un puzzle di cui si sono perse molte tessere e gli indizi a disposizione sono chiaramente insufficienti, sia che si propenda per ritenere tutto il ciclo dedicato alle storie di Daniele sia che si preferisca pensare a temi scelti anche in altri libri della Bibbia. Nella parete di fondo la presenza di una tavola imbandita, sulla destra, ha fatto pensare al convito di Baldassarre o ad un'Ultima Cena; la donna, sulla sinistra, è stata vista co
me Susanna proclamata innocente da Daniele o come Salomè. La parete sinistra, in cui il registro inferiore è per lo più perduto, risulta assolutamente
indecifrabile.
Quasi impossibile invece arrivare ad una definizione certa dei soggetti delle altre due pareti, perche ci si trova di fronte ad un puzzle di cui si sono perse molte tessere e gli indizi a disposizione sono chiaramente insufficienti, sia che si propenda per ritenere tutto il ciclo dedicato alle storie di Daniele sia che si preferisca pensare a temi scelti anche in altri libri della Bibbia. Nella parete di fondo la presenza di una tavola imbandita, sulla destra, ha fatto pensare al convito di Baldassarre o ad un'Ultima Cena; la donna, sulla sinistra, è stata vista co
me Susanna proclamata innocente da Daniele o come Salomè. La parete sinistra, in cui il registro inferiore è per lo più perduto, risulta assolutamente
indecifrabile.
Tutti i momenti del racconto biblico sono rappresentati dal Romanino in una rapida
sintesi, con un montaggio quasi cinematografico che alterna, senza soverchia
preoccupazione per le regole della prospettiva, il campo lungo al dettaglio, la figura intera al piano ravvicinato. E proprio in questo organizzato disordine, in questa spericolata vivacità narrativa sta il fascino straordinario di questi affreschi di Sant'Antonio, dove il Romanino costruisce figure meno monumentali e muscolose di
quelle di Pisogne ed accentua i toni grotteschi e il gusto per il dettaglio stravagante, disegnando direttamente con il pennello sull'intonaco e stendendo poi il colore che vibra, nei gialli, nei rossi e nei grigi, al mutevole divenire della luce. Si può comprendere allora, davanti alla sfrenata libertà del Romanino ed alla sua capacità di andare immediatamente al cuore di verità degli uomini e delle cose, l'entusiasmo provato dal Longhi e da Pasolini e le ammirate citazioni antiche, in piena età barocca, del Ridolfi (1648) e dell'Orlandi (1704), il quale scrive che "non mi poteva staccare dalle opere sue". Ma sono immagini davvero indimenticabili quelle che Romanino ha lasciato sulle pareti della chiesa di Sant'Antonio. Valgano per tutte il ragazzo seduto, nella parete sinistra, con la gamba a penzoloni dal cornicione che lancia uno sguardo beffardo al pubblico e con l'indice teso richiama ad una maggior attenzione o, nella parete destra, i trombettieri ingobbiti nello sforzo di dar fiato agli strumenti, la folla
un po'ebete che sta ai piedi dell'idolo e il mirabile scorcio dei due guerrieri riversi sul terreno, stretti nelle corrusche armature infiammate dai bagliori della fornace. E la sublime galleria di tipi che si affacciano dalle aeree balaustre, raccolti in gruppi ora signorilmente distratti ora partecipi agli eventi, coro vociante in cui nessuno però vuol perdere la propria individualità.
Prima di allontanarsi da Breno bisogna fare anche una visita al Museo Civico Camuno, dove, tra i dipinti, i reperti archeologici, gli oggetti di artigianato locale della collezione avviata nel 1903 da don Romolo Putelli, è custodita una piccola tela del Romanino, raffigurante il "Crocifisso". Non se ne conosce la provenienza, si tratta sicuramente, per le sue dimensioni e per il soggetto, di un'opera destinata alla devozione privata, da accostare a quell'altra tela del Romanino con il "Crocifisso e la Maddalena", che era nella collezione di Giovanni Testori e che è stata recentemente acquistata dalla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Entrambi i dipinti, per gli spunti tipicamente nordici e danubiani, vengono assegnati alla fase successiva al soggiorno a Trento e quindi agli anni in cui il nostro pittore era impegnato a Pisogne e a Breno. La figura del "Crocifisso" è presentata di fronte, con una prospettiva dal basso che accentua l'incombere del corpo di Cristo verso lo spettatore; il cielo notturno, percorso solo da qualche striatura di luce sulle nubi in basso, rimanda all'improvviso
oscurarsi del giorno che nel racconto evangelico segna la morte del Salvatore; il vento del terremoto soffia impetuoso ed agita all'aria il bianco perizoma, quasi annuncio di resurrezione. La profonda ed autentica spiritualità del Romanino ci
ha dato qui, ancora una volta, un'immagine meditativa di assoluta intensità.
Francesco De Leonardis
Notizie di Breno
|



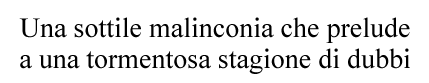
 la chiesa attuale sorse tra il 1467 e il 1516 sulla prima cappella con una serie di interventi successivi che portarono alla costruzione di un edificio ad aula unica, diviso in tre campate trapezoidali, molto irregolari, che si allargano in direzione del presbiterio; le campate sono ricoperte da volte a crociera che si collegano alle pareti laterali con archi acuti, mentre la parete di fondo (particolare nella immagine a lato) è a tutto sesto.
la chiesa attuale sorse tra il 1467 e il 1516 sulla prima cappella con una serie di interventi successivi che portarono alla costruzione di un edificio ad aula unica, diviso in tre campate trapezoidali, molto irregolari, che si allargano in direzione del presbiterio; le campate sono ricoperte da volte a crociera che si collegano alle pareti laterali con archi acuti, mentre la parete di fondo (particolare nella immagine a lato) è a tutto sesto. Difficile e complessa, a causa delle vaste lacune che interessano le zone affrescate, l'identificazione dell'iconografia, per la quale si sono suggerite letture a volte contrastanti. Non ci sono dubbi sulla parete destra che è anche la meglio conservata e raffigura alcuni episodi tratti dal libro di Daniele: Sadràch, Mesàch e Abdènego, compagni di Daniele, vengono condannati da Nabucodonosor e gettati nella fornace.
Difficile e complessa, a causa delle vaste lacune che interessano le zone affrescate, l'identificazione dell'iconografia, per la quale si sono suggerite letture a volte contrastanti. Non ci sono dubbi sulla parete destra che è anche la meglio conservata e raffigura alcuni episodi tratti dal libro di Daniele: Sadràch, Mesàch e Abdènego, compagni di Daniele, vengono condannati da Nabucodonosor e gettati nella fornace. Quasi impossibile invece arrivare ad una definizione certa dei soggetti delle altre due pareti, perche ci si trova di fronte ad un puzzle di cui si sono perse molte tessere e gli indizi a disposizione sono chiaramente insufficienti, sia che si propenda per ritenere tutto il ciclo dedicato alle storie di Daniele sia che si preferisca pensare a temi scelti anche in altri libri della Bibbia. Nella parete di fondo la presenza di una tavola imbandita, sulla destra, ha fatto pensare al convito di Baldassarre o ad un'Ultima Cena; la donna, sulla sinistra, è stata vista co
me Susanna proclamata innocente da Daniele o come Salomè. La parete sinistra, in cui il registro inferiore è per lo più perduto, risulta assolutamente
indecifrabile.
Quasi impossibile invece arrivare ad una definizione certa dei soggetti delle altre due pareti, perche ci si trova di fronte ad un puzzle di cui si sono perse molte tessere e gli indizi a disposizione sono chiaramente insufficienti, sia che si propenda per ritenere tutto il ciclo dedicato alle storie di Daniele sia che si preferisca pensare a temi scelti anche in altri libri della Bibbia. Nella parete di fondo la presenza di una tavola imbandita, sulla destra, ha fatto pensare al convito di Baldassarre o ad un'Ultima Cena; la donna, sulla sinistra, è stata vista co
me Susanna proclamata innocente da Daniele o come Salomè. La parete sinistra, in cui il registro inferiore è per lo più perduto, risulta assolutamente
indecifrabile.