Situata all'estremità della sponda orientale del Sebino, Pisogne è allo stesso tempo l'ultima località rivierasca e il primo paese della Valcamonicamonica. Punto di confluenza tra le vie di terra e la via del lago, prima che venisse costruita la strada costiera fu per secoli l' "emporio" della Valle: qui giungeva la strada Valeriana che attraverso il Tonale e l'Aprica collegava il Bresciano con il Trentino e la Valtellina; da qui si dipartivano le due direttrici montane che attraverso la Colma di S. Zeno conducevano l'una in Val Trompia e l'altra, per il Passo della Croce, a Zone e a Marone; da qui aveva inizio la strada che, superato l'Oglio, giungeva a Lovere e a Bergamo. Il porto, infine, era il capolinea obbligato della via lacustre, l'unica per le merci dirette o provenienti dalla Valcamonica fino al 1850, anno di costruzione della litoranea per Marone e Iseo, mentre al 1907 risale l'attivazione della ferrovia Brescia-Pisogne-Breno.
 Già a inizio Seicento al mercato di Pisogne (ricordato per la prima volta nel 1229) confluivano granaglie, vini, canapi, panni, olio, castagne, carni e soprattutto le ferrarezze della Valcamonica e vi accorrevano mercanti da tutta la Lombardia. Fin da allora inoltre il paese era centro siderurgico tra i principali, grazie soprattutto al ferro delle miniere della valle di Govine, dove sorgevano due forni e quattro fucine. A inizio Ottocento nel paese erano attive sei vaste "dogane" per ferri e mercanzie, otto fondachi per i legnami settimanalmente provenienti dalla Valle, due piazze per il mercato bestiami ed un'altra vastissima per i grani ed altri generi, quest'ultima contornata da trenta e più botteghe con porticati, mentre in paese venticinque osterie ospitavano i forestieri di passaggio. Quattro navi-corriere prestavano servizio permanente sul lago oltre alle molte barche. Nel corso del secolo al commercio e alla siderurgia si aggiunsero le filande da seta e, a inizio del Novecento, lo sfruttamento delle cave di gesso, poste alle spalle del paese e tuttora in attività.
Già a inizio Seicento al mercato di Pisogne (ricordato per la prima volta nel 1229) confluivano granaglie, vini, canapi, panni, olio, castagne, carni e soprattutto le ferrarezze della Valcamonica e vi accorrevano mercanti da tutta la Lombardia. Fin da allora inoltre il paese era centro siderurgico tra i principali, grazie soprattutto al ferro delle miniere della valle di Govine, dove sorgevano due forni e quattro fucine. A inizio Ottocento nel paese erano attive sei vaste "dogane" per ferri e mercanzie, otto fondachi per i legnami settimanalmente provenienti dalla Valle, due piazze per il mercato bestiami ed un'altra vastissima per i grani ed altri generi, quest'ultima contornata da trenta e più botteghe con porticati, mentre in paese venticinque osterie ospitavano i forestieri di passaggio. Quattro navi-corriere prestavano servizio permanente sul lago oltre alle molte barche. Nel corso del secolo al commercio e alla siderurgia si aggiunsero le filande da seta e, a inizio del Novecento, lo sfruttamento delle cave di gesso, poste alle spalle del paese e tuttora in attività.
Il ruolo economico di Pisogne nei secoli scorsi spiega la dimensione e la struttura urbanistica del centro storico, che presenta le caratteristiche di una cittadina e rimanda alla configurazione dei comparti medievali, quando il borgo "de Pixogni" era incentrato su una via matrice (le attuali vie Torrazzo e S. Marco), parallela al lago e intersecata, quasi nel mezzo, da un ampio slargo adibito a luogo di mercato. Da questo nucleo presero poi corpo verso monte la piazza anteposta alla parrocchiale settecentesca e, verso lago, l'ottocentesca piazza Umberto I, ricavata con l'interramento di una palude.
La ferrovia e la rotabile, tracciate nell'Ottocento, hanno alterato il tradizionale rapporto dell'abitato con il lago, che avveniva, come di consueto, oltre che dalla piazza anche attraverso stretti percorsi ortogonali che si diramavano dalla strada interna e una serie di spazi articolati, di slarghi e attracchi.
La "piazza Grande", che riunisce le tre piazze contigue (piazza Vescovo Corna Pellegrini, del Mercato e Umberto I), costituisce il fulcro del centro per gli spazi e gli edifici pubblici e privati che vi si affacciano. Sviluppata con un andamento lievemente in salita da ovest a est, è dominata su un lato dalla medievale Torre del Vescovo e sull'altro dalla parrocchiale settecentesca. Ai lati è orlata da una sequenza irregolare di portici di diverse dimensioni e livelli e vi prospettano alcuni edifici appartenenti alle famiglie protagoniste della storia economica del paese: casa Damioli (con diversi corpi di fabbrica che vanno dal Seicento agli anni Trenta del nostro secolo, e il cui giardino di notevole interesse botanico è stato in parte trasformato in parco pubblico), casa Giordani (secoli XV-XIX), casa Bertolassi (XVII-XIX ma appoggiata ad una torre medievale nella quale è forse da identificare il "Torrazzo" cioè la residenza del vicario vescovile), casa Ghitti (settecentesca ma con elementi del XV secolo).
I due edifici di maggior prestigio sono però certamente la Torre del Vescovo e la parrocchiale.
La prima, eretta nel 1250, ricorda il lungo periodo durante il quale Pisogne, per l'importanza della sua ubicazione e del suo ruolo economico, fu feudo del vescovo di Brescia (a partire probabilmente dall'alto medioevo fino al 1462). A quei secoli, nei
quali Pisogne fu al centro di contese tra Brescia e Bergamo, prima, e con i ghibellini di Valcamonica poi, risale anche la fortificazione del borgo con mura e castello: delle mura restano tracce inserite in edifici successivi (vicolo S. Clemente e vicolo tra piazza del Mercato e via dell'Ortaglia), tre porte (via Torrazzo, via dei Monti e via Mercanti) e un "Torricello" (vicolo S. Clemente).
 Sullo sfondo della piazza del Mercato, verso monte, sta la parrocchiale, costruita su progetto di Antonio Marchetti (1768-84) e portata a termine da Gaspare Turbini (1791-94); l'ornamentazione interna e il completamento delle cappelle si protrassero per buona parte del secolo successivo fino alla consacrazione avvenuta nel 1881.
L'interno, a navata unica scandita in tre campate cui corrispondono altrettante cappelle per ogni lato, contiene statue in stucco del Serena (sui timpani delle cappelle centrali), affreschi e tele di Sante Cattaneo (nella volta del presbiterio), di Gaetano Cresseri (nella cappella di S. Costanzo), di Antonio Guadagnini (primo altare di sinistra), di Giosuè Sala e Felice Campi (nella volta della navata), di Antonio Gandino. Nel presbiterio un bell'organo di forme neoclassiche del Serassi (1857) fronteggia la parte lignea cinquecentesca dell'organo più antico portato qui dalla pieve.
Sullo sfondo della piazza del Mercato, verso monte, sta la parrocchiale, costruita su progetto di Antonio Marchetti (1768-84) e portata a termine da Gaspare Turbini (1791-94); l'ornamentazione interna e il completamento delle cappelle si protrassero per buona parte del secolo successivo fino alla consacrazione avvenuta nel 1881.
L'interno, a navata unica scandita in tre campate cui corrispondono altrettante cappelle per ogni lato, contiene statue in stucco del Serena (sui timpani delle cappelle centrali), affreschi e tele di Sante Cattaneo (nella volta del presbiterio), di Gaetano Cresseri (nella cappella di S. Costanzo), di Antonio Guadagnini (primo altare di sinistra), di Giosuè Sala e Felice Campi (nella volta della navata), di Antonio Gandino. Nel presbiterio un bell'organo di forme neoclassiche del Serassi (1857) fronteggia la parte lignea cinquecentesca dell'organo più antico portato qui dalla pieve.
Collocata su un poggio sulla strada per Fraine sorge la chiesa più antica del paese, la pieve di S. Maria in Silvis. La posizione esterna all'abitato rimanda alla funzione di riferimento ricoperto dalla pieve rispetto a tutto l'ampio territorio costellato di insediamenti della valle del Trobiolo e delle singole parrocchie formatesi nel tempo. L'edificio è originario del X secolo e fu ricostruito o meglio riformato, secondo l'iscrizione sul portale, nel 1485. La facciata, estremamente semplice secondo un modulo tardo romanico, è arricchita da un portale in arenaria rossa e da decorazione pittorica a finti conci di gusto rinascimentale. L'interno a navata unica, arcaico nell'architettura, è ricoperto di affreschi votivi dei secoli XV e XVI di notevole interesse nonostante le non buone condizioni di conservazione dovute a eccesso di umidità e alle aperture di epoche più tarde; sono stati recentemente attribuiti, oltre che a Giovanni da Marone, a Giovanni Pietro da Cemmo e alla sua scuola.
Vanto principale di Pisogne è la quattrocentesca chiesa della Madonna della Neve, il cui interno è completamente decorato da gli affreschi del Romanino. Posta al margine dell'abitato, poco prima della pieve, faceva parte di un convento agostiniano. La facciata è dipinta a rombi policromi e coronata da archetti, mentre il bei portale in arenaria è sormontato da una statua della Madonna col Bambino; sotto il portichetto del fianco sinistro si sono conservati resti di affreschi, tra cui una Danza macabra (1486), attribuiti a Giovanni da Marone.
A sud del paese sulla litoranea, nella frazione di Govine, sorge anche il santuario
della Natività di Maria, eretto nel 1631 per ringraziamento dallo scampato pericolo della peste. L'abitato riflette, nella disposizione "in serie" degli edifici più antichi che risalgono un torrentello, la trascorsa tradizione di centro per la lavorazione del ferro.
Data la vastità del territorio comunale, che dal lago giunge al monte Guglielmo e comprende varie frazioni in zona montana (Fraine, Grignaghe, Siniga, Sonvico, Sedergnò), tre sulla costa (Pontasio, Toline e Govine) e una all'inizio della Valcamonica (Gratacasolo), da Pisogne è possibile effettuare visite sia ai centri minori che alle località montane, in particolare alla val Palot, sede di recenti insediamenti turistici, dalla quale, superata la fresca zona di pinete posta sulla pendice settentrionale del monte Guglielmo, si arriva alla colma di S. Zeno
(m. 1434), spartiacque con la Val Trompia, e da qui al rifugio Piardi e alla cima del Guglielmo (m. 1940).
Gabriella Motta
Pagina Precedente
|
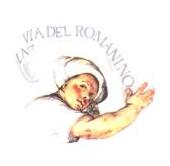



 Già a inizio Seicento al mercato di Pisogne (ricordato per la prima volta nel 1229) confluivano granaglie, vini, canapi, panni, olio, castagne, carni e soprattutto le ferrarezze della Valcamonica e vi accorrevano mercanti da tutta la Lombardia. Fin da allora inoltre il paese era centro siderurgico tra i principali, grazie soprattutto al ferro delle miniere della valle di Govine, dove sorgevano due forni e quattro fucine. A inizio Ottocento nel paese erano attive sei vaste "dogane" per ferri e mercanzie, otto fondachi per i legnami settimanalmente provenienti dalla Valle, due piazze per il mercato bestiami ed un'altra vastissima per i grani ed altri generi, quest'ultima contornata da trenta e più botteghe con porticati, mentre in paese venticinque osterie ospitavano i forestieri di passaggio. Quattro navi-corriere prestavano servizio permanente sul lago oltre alle molte barche. Nel corso del secolo al commercio e alla siderurgia si aggiunsero le filande da seta e, a inizio del Novecento, lo sfruttamento delle cave di gesso, poste alle spalle del paese e tuttora in attività.
Già a inizio Seicento al mercato di Pisogne (ricordato per la prima volta nel 1229) confluivano granaglie, vini, canapi, panni, olio, castagne, carni e soprattutto le ferrarezze della Valcamonica e vi accorrevano mercanti da tutta la Lombardia. Fin da allora inoltre il paese era centro siderurgico tra i principali, grazie soprattutto al ferro delle miniere della valle di Govine, dove sorgevano due forni e quattro fucine. A inizio Ottocento nel paese erano attive sei vaste "dogane" per ferri e mercanzie, otto fondachi per i legnami settimanalmente provenienti dalla Valle, due piazze per il mercato bestiami ed un'altra vastissima per i grani ed altri generi, quest'ultima contornata da trenta e più botteghe con porticati, mentre in paese venticinque osterie ospitavano i forestieri di passaggio. Quattro navi-corriere prestavano servizio permanente sul lago oltre alle molte barche. Nel corso del secolo al commercio e alla siderurgia si aggiunsero le filande da seta e, a inizio del Novecento, lo sfruttamento delle cave di gesso, poste alle spalle del paese e tuttora in attività. Sullo sfondo della piazza del Mercato, verso monte, sta la parrocchiale, costruita su progetto di Antonio Marchetti (1768-84) e portata a termine da Gaspare Turbini (1791-94); l'ornamentazione interna e il completamento delle cappelle si protrassero per buona parte del secolo successivo fino alla consacrazione avvenuta nel 1881.
L'interno, a navata unica scandita in tre campate cui corrispondono altrettante cappelle per ogni lato, contiene statue in stucco del Serena (sui timpani delle cappelle centrali), affreschi e tele di Sante Cattaneo (nella volta del presbiterio), di Gaetano Cresseri (nella cappella di S. Costanzo), di Antonio Guadagnini (primo altare di sinistra), di Giosuè Sala e Felice Campi (nella volta della navata), di Antonio Gandino. Nel presbiterio un bell'organo di forme neoclassiche del Serassi (1857) fronteggia la parte lignea cinquecentesca dell'organo più antico portato qui dalla pieve.
Sullo sfondo della piazza del Mercato, verso monte, sta la parrocchiale, costruita su progetto di Antonio Marchetti (1768-84) e portata a termine da Gaspare Turbini (1791-94); l'ornamentazione interna e il completamento delle cappelle si protrassero per buona parte del secolo successivo fino alla consacrazione avvenuta nel 1881.
L'interno, a navata unica scandita in tre campate cui corrispondono altrettante cappelle per ogni lato, contiene statue in stucco del Serena (sui timpani delle cappelle centrali), affreschi e tele di Sante Cattaneo (nella volta del presbiterio), di Gaetano Cresseri (nella cappella di S. Costanzo), di Antonio Guadagnini (primo altare di sinistra), di Giosuè Sala e Felice Campi (nella volta della navata), di Antonio Gandino. Nel presbiterio un bell'organo di forme neoclassiche del Serassi (1857) fronteggia la parte lignea cinquecentesca dell'organo più antico portato qui dalla pieve.