Posto nella Val Grigna, valle laterale di sinistra della media Valcamonica, il
nucleo storico del paese si sviluppa in salita lungo l'asse della via principale fino alla parrocchiale, che ne costituisce il perno
settentrionale, con il bel sagrato fronteggiato dalle cime della Concarena e della Presolana. Sul fianco orientale invece le
case, allineate quasi a schiera, seguono con andamento sinuoso le linee di pendenza, affacciandosi alla profonda incisione
del torrente e allo strapiombo di via Ripa, provocato da una rovinosa inondazione nel 1634.
Alcuni edifici di impianto medievale, resti di stipiti, di mura d'arenaria rossa, di portali e qualche palazzo di particolare decoro testimoniano ancora l'antichità e il rilievo economico del paese nei secoli passati.
In epoca medievale il borgo, che fu feudo del Vescovo di Brescia, era fortificato: si sono conservate quattro torri e sono ancora visibili le due porte (una verso la parrocchiale con pietra angolare e torre sovrastante, e una in via Luzzana, verso la strada che conduceva ai vigneti); sulla sommità dell'abitato, dove ora si trova la parrocchiale, sorgeva probabilmente un forte.
Alcuni scavi eseguiti nel 1993-94 in occasione della ripavimentazione della chiesa di S. Maria hanno messo in luce quattro livelli archeologici che confermano l'antichità non solo dell'insediamento ma forse anche dell'attività siderurgica. Nel livello inferiore si sono trovati i resti di un edificio di età romana rimasto in uso tra il I e il IV secolo. In età altomedievale sopra le macerie dell'edificio romano sorsero modeste capanne lignee: una di queste, dotata di un focolare con il fondo costituito da una grande lastra di granito, intorno al quale si sono ritrovate anche numerose scorie ferrose, era forse un impianto artigianale per la lavorazione del ferro. Nel Basso medioevo l'area fu occupata da un imponente edificio fortificato a pianta quadrangolare (una casa-torre), appartenente probabilmente ad una nobile famiglia locale. La quarta fase infine riguarda
la costruzione della chiesa di S. Maria in età rinascimentale.
Del nucleo più antico dell'abitato facevano parte anche le caratteristiche case di via Contrizio e di via di Mezzo; alcune, con ampi loggiati a più arcate, sono quattro-cinquecentesche e presentano talvolta eleganti portali.
I secoli di maggiore sviluppo e ricchezza del paese furono il Sei e il Settecento, quando Bienno fu centro di fucine e di commercio di ferrarezze tra i più importanti della Valle, attività che portarono alcune famiglie biennesi a fiorenti condizioni economiche. Lo testimoniano l'ampliamento dell'abitato e il prestigio di parecchi edifici, come quelli che fiancheggiano la via principale (via Fantoni), in particolare il palazzo Simoni-Fè d'Ostiani (già sede dell'asilo ed ora della biblioteca), o casa Tempini, con sale finemente decorate, o palazzo Francesconi, di fronte all'ingresso della parrocchiale, con ampia e ariosa loggia aperta sul panorama del paese e una grande galleria interamente affrescata di probabile mano del Fiamminghino.
 Nel Seicento erano ben una quindicina i magli funzionanti, oltre a sei forge "per farranze" tre mulini e una segheria; nel 1870 le fucine erano aumentate a 24 e producevano strumenti da cucina e da lavoro venduti non solo in Italia. Tuttora sono attive cinque fucine idrauliche. una delle quali è stata trasformata in museo etnografico didattico per la dimostrazione dei metodi di lavorazione tradizionale. Le ruote ad acqua e gli impianti di insufflazione fin dal XVl secolo erano azionati dall'acqua del Vaso Re, un antico canale (forse esistente già nel XIII secolo) che preleva acqua da un ramo del torrente Grigna e che attraversa i comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine fino a confluire nel fiume Oglio. I salti d'acqua artificiali, cadendo dalla condotta aerea sopra le ruote sospese sul canale di scarico sottostante le mettevano in moto azionando i magli e le macine.
Nel Seicento erano ben una quindicina i magli funzionanti, oltre a sei forge "per farranze" tre mulini e una segheria; nel 1870 le fucine erano aumentate a 24 e producevano strumenti da cucina e da lavoro venduti non solo in Italia. Tuttora sono attive cinque fucine idrauliche. una delle quali è stata trasformata in museo etnografico didattico per la dimostrazione dei metodi di lavorazione tradizionale. Le ruote ad acqua e gli impianti di insufflazione fin dal XVl secolo erano azionati dall'acqua del Vaso Re, un antico canale (forse esistente già nel XIII secolo) che preleva acqua da un ramo del torrente Grigna e che attraversa i comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine fino a confluire nel fiume Oglio. I salti d'acqua artificiali, cadendo dalla condotta aerea sopra le ruote sospese sul canale di scarico sottostante le mettevano in moto azionando i magli e le macine.
Recenti ritrovamenti (1994) sulla sponda destra di Val Gabbia aprono però un nuovo capitolo nella storia siderurgica biennese. Si tratta del rinvenimento di resti di numerose miniere di ferro, che non erano mai state segnalate per questa zona della valle, sul fianco settentrionale del Dosso Acuto, miniere che paiono essere state intensamente sfruttate per secoli. Nei pressi degli imbocchi delle gallerie vi sono i resti di forni di arrostimento del minerale, mentre sulla riva destra del torrente Gabbia la presenza di un deposito di carbone ha permesso di ipotizzare l'esistenza di un forno fusorio che risalirebbe all'Alto Medioevo.
Il benessere del paese nei secoli scorsi è testimoniato anche dagli importanti edifici religiosi. La parrocchiale, costruita forse nel XV secolo e riedificata nel XVII su progetto di Pietro Maria Bagnatore, ha un portale in pietra di sarnico; internamente la navata unica si chiude con una maestosa volta a tutto centro, dipinta in forma di un grande loggiato con balaustrate, fregi, capitelli e putti. La maggior parte degli affreschi sono dovuti ad Antonio Cappello di Brescia ed a Giovanni Mauro della Rovere detto il Fiamminghino (1621); le opere lignee sono opera dei Ramus e l'organo seicentesco è dei fratelli Antegnati. Di particolare interesse anche le trecentesche cancellate in ferro battuto che chiudono le cappellette laterali. Sull'altare maggiore in marmi policromi la pala del veneziano Giovan Battista Pittoni rappresenta il martirio dei santi Faustino e Giovita, ai quali la chiesa è dedicata.
La chiesa di S. Maria Annunciata, eretta verso il 1450 in sostituzione di una prima chiesa che sorgeva in "contrada della Ripa" accanto ad un piccolo convento agostiniano, è quasi interamente decorata da affreschi attribuiti a Giovanni Pietro Da Cemmo, oltre a quelli più celebri del Romanino. La pala dell'altare maggiore (Annunciazione) è del Fiamminghino, mentre le statue lignee sono attribuite a Beniamino Simoni. Esternamente la facciata conserva affreschi di epoche diverse, tra i quali il più antico è un san Cristoforo.
La piccola chiesa di S. Pietro in Vincoli, detta S. Pietro "in Zuc", sorge poco prima dell'abitato sulla strada per Breno; aperta entro una torre medievale mozzata sul luogo di un antico cimitero di età forse romana, fu successivamente usata in età cristiana e affiancata da un ospizio.
Il santuario della Maddalena, che sorge sul colle omonimo, conserva in un locale sotterraneo, detto sala di S. Marta, pregevoli affreschi quattrocenteschi attribuiti a Pietro Giovanni da Cemmo; in una cappelletta a volta sta il Sepolcro composto da dodici statue lignee policrome di Paolo Amatore, mentre un'altra cappella è stata trasformata in supporto della imponente statua laminata in oro di Cristo Re eretta nel 1931.
Su un'altura dominante tutta la bassa valle fino al lago d'Iseo, sorge infine, in uno scenario suggestivo, l'Eremo di S. Pietro, antico cenobio francescano che la tradizione vuole fondato da S. Antonio da Padova nel XIII secolo: completamente riedificato in anni recenti, conserva resti di architettura e di affreschi dei secoli XIV e XV.
Da Bienno sono possibili passeggiate ed escursioni verso le cime di Campolungo, San Glisente, il lago della Vacca, Bazena e Croce Domini.
Gabriella Motta
Pagina Precedente
|
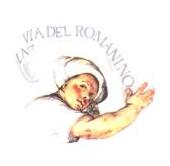



 Nel Seicento erano ben una quindicina i magli funzionanti, oltre a sei forge "per farranze" tre mulini e una segheria; nel 1870 le fucine erano aumentate a 24 e producevano strumenti da cucina e da lavoro venduti non solo in Italia. Tuttora sono attive cinque fucine idrauliche. una delle quali è stata trasformata in museo etnografico didattico per la dimostrazione dei metodi di lavorazione tradizionale. Le ruote ad acqua e gli impianti di insufflazione fin dal XVl secolo erano azionati dall'acqua del Vaso Re, un antico canale (forse esistente già nel XIII secolo) che preleva acqua da un ramo del torrente Grigna e che attraversa i comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine fino a confluire nel fiume Oglio. I salti d'acqua artificiali, cadendo dalla condotta aerea sopra le ruote sospese sul canale di scarico sottostante le mettevano in moto azionando i magli e le macine.
Nel Seicento erano ben una quindicina i magli funzionanti, oltre a sei forge "per farranze" tre mulini e una segheria; nel 1870 le fucine erano aumentate a 24 e producevano strumenti da cucina e da lavoro venduti non solo in Italia. Tuttora sono attive cinque fucine idrauliche. una delle quali è stata trasformata in museo etnografico didattico per la dimostrazione dei metodi di lavorazione tradizionale. Le ruote ad acqua e gli impianti di insufflazione fin dal XVl secolo erano azionati dall'acqua del Vaso Re, un antico canale (forse esistente già nel XIII secolo) che preleva acqua da un ramo del torrente Grigna e che attraversa i comuni di Bienno, Berzo Inferiore ed Esine fino a confluire nel fiume Oglio. I salti d'acqua artificiali, cadendo dalla condotta aerea sopra le ruote sospese sul canale di scarico sottostante le mettevano in moto azionando i magli e le macine.